
Di fronte a tutto ciò che precede, bisogna considerare d’altra parte che, in seguito ad un’attività preponderante dei nervi, le grandi facoltà intellettuali producono un aumento eccessivo dell’attitudine a sentire il dolore sotto tutte le forme; che inoltre il temperamento passionato che ne è la condizione, come pure la vivacità e la perfezione più grande di ogni percezione, che ne sono inseparabili, danno alle emozioni così prodotte una violenza senza confronto più forte; ora si sa che le emozioni dolorose sono molto più frequenti che le piacevoli; finalmente bisogna anche ricordare che le alte facoltà intellettuali fanno di chi le possiede un uomo straniero agli altri uomini ed alle loro agitazioni, visto che più questi possiede in sé stesso, meno può trovare in altrui. Mille oggetti per i quali costoro prendono un piacere infinito, a lui sembrano insipidi e ripugnanti. Forse in tal maniera la legge di compensazione che regna dovunque, domina egualmente qui pure. Non si è forse preteso bene spesso e non senza qualche apparenza di ragione, che in fondo l’uomo più povero di spirito è il più felice? Comunque si sia, nessuno gl’invidierà questa felicità. Io non voglio anticipare sul lettore per la soluzione definitiva di tale questione, tanto più perché Sofocle stesso ha espresso su ciò giudizi diametralmente opposti: Il sapere è di molto la porzione più considerevole della felicità Antigone. Un’altra volta disse: La vita del saggio non è la più piacevole Ajace. I filosofi dell’Antico Testamento non vanno meglio d’accordo tra loro; Gesù, figlio di Sirac, ha detto: La vita dello stolto è peggior della morte 22, 12; l’Ecclesiaste invece 1, 18: Dove molta sapienza, ivi molto dolore.
Frattanto ci tengo a ricordar qui che ciò che si disegna più particolarmente con una parola propria esclusivamente della lingua tedesca, Philister borghese, droghiere, filisteo, si è precisamente l’uomo che, in seguito alla misura limitata e strettamente sufficiente delle sue forze intellettuali, non ha bisogni spirituali; tale espressione appartiene alla vita da studenti, ed è stata messa in uso più tardi in un rispetto più elevato, ma analogo ancora al suo senso primitivo, per qualificare colui che è l’opposto d’un figlio delle Muse, vale a dire un uomo affatto prosaico. Costui infatti è e resta l’αµουσος ανηρ l’uomo non iniziato alle Muse. Ponendomi ad un punto di vista più alto ancora vorrei definire i filistei dicendo che sono gente costantemente occupata, e ciò colla più gran serietà del mondo, d’una realtà che non è realtà. Ma questa definizione, già d’una natura trascendentale, non sarebbe in armonia col punto di vista popolare a cui mi son messo in questa dissertazione; potrebbe quindi non esser compresa da tutti i lettori. La prima invece ammette più facilmente un commento specifico, e disegna abbastanza l’essenza e la radice delle proprietà caratteristiche tutte del filisteo. Costui è dunque, come dicemmo, un uomo senza bisogni spirituali.
Da ciò derivano molte conseguenze: la prima, in rapporto a lui stesso, si è che non avrà mai gioie spirituali, secondo la massima già citata che non vi sono veri piaceri se non con veri bisogni. Nessuna aspirazione ad acquistar conoscenze e giudizi nuovi per le cose in sé stesse anima la sua esistenza: e nessuna aspirazione ai piaceri estetici, perocché queste due aspirazioni sono strettamente legate assieme. Quando la moda o qualche altro stimolo gl’impone tali piaceri ei se ne sbriga nel modo più breve possibile, come un galeotto si sbriga del suo lavoro forzato. Soli piaceri per lui sono i sensuali, su di essi egli prende il suo compenso. Mangiar ostriche, bever vino di Champagne, ecco per lui l’apice dell’esistenza; procurarsi tutto quanto contribuisce al benessere materiale, ecco lo scopo della sua vita.
Troppo felice quando tale scopo lo occupa abbastanza! Perocché se questi beni gli sono stati già concessi anticipatamente, ei diventa preda della noia; per cacciarla prova tutto ciò che si può immaginare; balli, teatri, società, giuochi di carte, giuochi d’azzardo, cavalli, donne, ebbrezza, viaggi, ecc. E nullameno tutto questo non basta quando l’assenza di bisogni intellettuali rende impossibili i piaceri dello spirito. Così una serietà fosca e secca, molto simile a quella dell’animale, è propria del filisteo e lo caratterizza. Niente lo diverte, niente lo scuote, niente risveglia il suo interesse. I piaceri materiali sono presto esauriti; la società, composta di filistei suoi pari, gli viene ben tosto a noia; il giuoco delle carte finisce collo stancarlo. Gli restano rigorosamente parlando le soddisfazioni della vanità alla sua maniera: esse consisteranno a sorpassare gli altri nelle ricchezze, nel grado, nell’influenza o nel potere, ciò che allora gli vale la loro stima; oppure anche ei cercherà di potersi almeno fregare intorno a coloro che brillano per tali vantaggi, e di riscaldarsi ai riflessi del loro splendore in inglese questo si chiama snob.
La seconda conseguenza che risulterebbe dalla proprietà fondamentale che abbiamo riscontrata nel filisteo, si è che in rapporto agli altri, siccome è privo di bisogni intellettuali, e limitato ai soli materiali, cercherà gli uomini che potranno soddisfare questi ultimi, e non coloro che potrebbero provvedere ai primi. Sicché non sono certamente le alte qualità intellettuali che chiede loro; che anzi quando le incontra eccitano la sua antipatia, e fors’anche il suo odio, perocché ei non prova in loro presenza se non un sentimento importuno d’inferiorità ed un’invidia sorda, secreta, che nasconde colla più gran cura, che cerca di dissimulare a sé stesso, ma che giusto per questo cresce talora fino ad una rabbia muta. Non è mica sulle facoltà dello spirito che costui penserà mai a misurare la sua stima o la sua considerazione; ei le riserverà esclusivamente al grado ed alla ricchezza, al potere ed all’influenza, cose che passano a’ suoi occhi come le sole qualità vere, le sole in cui può aspirare di eccellere. E tutto ciò perché il filisteo è un uomo privo di bisogni intellettuali. Il suo estremo soffrire deriva dal fatto che le idealità non gli portano alcun divertimento, e che, per sfuggire la noia, ei deve sempre ricorrere alle realtà. Ora queste da una parte sono ben presto esaurite, ed allora in luogo di far piacere, stancano; e dall’altra portano con sé sciagure d’ogni fatta, mentre le idealità sono inesauribili e per sé stesse innocue.
In tutta questa dissertazione sulle condizioni personali che contribuiscono alla nostra felicità, ebbi in vista le qualità fisiche, e principalmente le qualità intellettuali. Si è nella mia memoria sul Fondamento della morale § 22 che ho esposto come la perfezione morale, a sua volta, influisca direttamente sulla felicità: a quest’opera invito il lettore.
Aforismi sulla saggezza nella vita
Traduzione Oscar D. ChilesottiIl dolore, e la noia. L'intelligenza
Pinterest • Giancarlo Vitali •










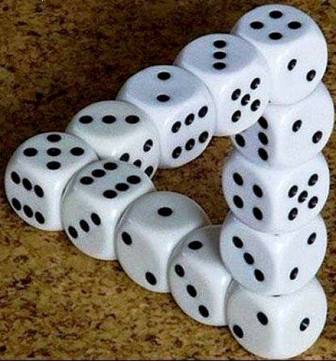

Ancora nessun commento