
Se la gloria di Balzac (1799-1850) è fondata sulla Commedia umana, cioè sul grande affresco della società francese del suo tempo, non è men vero che le opere fantastiche hanno un posto di rilievo nella sua produzione, specie nel primo periodo, quando egli era più influenzato dall’occultismo di Svedenborg. Un romanzo fantastico, La peau de chagrin (1831) resta tra i suoi capolavori. Ma anche nei suoi romanzi più celebrati come realistici, c’è una forte parte di trasfigurazione fantastica che è un elemento essenziale della sua arte.
Quando Balzac intraprese il progetto della Commedia umana, la sua narrativa fantastica giovanile fu relegata al margine della sua opera; così il racconto L’élixir de longue vie, già pubblicato in rivista nel 1830, fu ripubblicato tra gli Etudes philosophiques, preceduto da un cappello che lo presentava come uno studio sociale sugli eredi impazienti della morte dei genitori. Aggiunta artificiosa, di cui non ho tenuto conto; è il testo della prima versione che qui presento.
Lo scienziato satanico è un vecchio tema medievale e rinascimentale (Faust, le leggende degli alchimisti) che l’Ottocento prima romantico, poi simbolista saprà far fruttare (basti ricordare il Frankestein di Mary Shelley, che solo perché troppo lungo non figura nella nostra raccolta) e che sarà ereditato dalla fantascienza.
Qui siamo in un’approssimativa Ferrara cinquecentesca. Un vecchio ricchissimo s’è procurato un unguento orientale che fa resuscitare i morti. Balzac ha molte idee, forse troppe: l’Italia rinascimentale pagana e papale, la Spagna bigotta e penitenziale, la sfida alchimistica alle leggi della natura, la dannazione di Don Giovanni (con una curiosa variante: è lui che diventa convitato di pietra), e un finale spettacolare tutto di gran pompe chiesastiche e sarcasmi blasfemi. Ma il racconto s’impone per gli effetti macabri delle parti del corpo che vivono da sole: un occhio, un braccio, e anche una testa che si stacca dal corpo morto e morde il cranio d’un vivo, come il conte Ugolino nell’Inferno.
In un sontuoso palazzo di Ferrara, una sera d’inverno, Don Giovanni Belvidero offriva una festa in onore di un principe d’Este. A quell’epoca una festa era uno spettacolo meraviglioso quale solo regali ricchezze o la potenza di un signore potevano offrire. Sedute a un tavolo illuminato da candele profumate, sette cortigiane scambiavano dolci frasi, circondate da splendidi capolavori i cui marmi bianchi spiccavano sulle pareti di stucco rosso e contrastavano con i ricchi tappeti di Turchia. Vestite di raso, scintillanti d’oro e cariche di pietre preziose meno lucenti dei loro occhi, tutte esprimevano passioni forti, ma diverse come diversa era la loro bellezza. Non differivano fra di loro né per le parole né per le idee; il portamento, uno sguardo, un gesto o il tono di voce servivano alle loro parole da contrappunto libertino, lascivo, malinconico o canzonatorio.
Una sembrava dire: La mia bellezza sa riscaldare il cuore gelido dei vecchi.
L’altra: È una gioia per me adagiarmi sui cuscini, e pensare con ebbrezza a quelli che mi adorano.
Una terza, nuova a tali feste, si studiava di arrossire. In fondo al cuore provo rimorso diceva. Sono cattolica, e ho paura dell’inferno. Ma vi amo tanto, oh! tanto e tanto, che posso sacrificarvi l’eternità. La quarta, vuotando una coppa di vino di Chio, esclamava: Viva la gaiezza! Vivo un’esistenza nuova a ogni nuova aurora! Dimentica del passato, ancora ebbra degli assalti della sera precedente, tutte le sere consumo una vita di felicità, una vita piena d’amore!.
La donna seduta accanto a Belvidero lo guardava con occhi fiammeggianti. Era silenziosa. Non mi rivolgerei a dei bravi per uccidere il mio amante se mi abbandonasse. Poi aveva riso, ma la mano spezzava con gesto convulso una confettiera d’oro prodigiosamente cesellata.
«Quando sarai granduca?» chiese la sesta al principe con un’espressione di gioia omicida nei denti, e un delirio bacchico negli occhi.
«E tu? Quando morrà tuo padre?» esclamò la settima ridendo, e gettando il suo mazzo di fiori a Don Giovanni in un gesto di inebriante provocazione. Era una creatura innocente abituata a giocare con tutte le cose sacre.
«Ah! Non me ne parlate» ribatté il giovane e bel Don Giovanni Belvidero. «Vi è solo un padre eterno nel mondo, e disgrazia vuole che lo abbia io!»
Le sette cortigiane di Ferrara, gli amici di Don Giovanni e lo stesso principe diedero in un grido di orrore. Duecento anni dopo e sotto Luigi XV la gente di buon gusto avrebbe riso di queste parole. Ma all’inizio di un’orgia le anime erano forse ancora troppo lucide? A dispetto del fuoco delle candele, del grido delle passioni, dei vasi d’oro e d’argento, dei fumi del vino, a dispetto della contemplazione delle donne più incantevoli, vi era forse ancora, in fondo ai cuori, quel rispetto per le cose umane e divine che lotta fino a che l’orgia l’abbia annegato negli ultimi fiotti di un vino scintillante? Pure, i fiori erano già stati sgualciti, gli occhi erano inebetiti, e l’ebbrezza arrivava, secondo l’espressione di Rabelais, fino ai sandali. In quel momento di silenzio si aprì una porta, e, come al banchetto di Baldassarre, Dio si fece riconoscere, sotto la forma di un vecchio domestico dai capelli bianchi, il passo tremante, le sopracciglia contratte; entrò con aria triste, fece sfiorire con uno sguardo le corone, le coppe di vermeil, le piramidi di frutta, lo splendore della festa, l’incarnato acceso dei volti stupiti e i colori dei cuscini sgualciti dalle bianche braccia delle donne; in breve, gettò un velo di lutto su quella follia dicendo con voce tetra: «Monsignore, vostro padre muore».
Don Giovanni si alzò, rivolgendo ai suoi ospiti un gesto che pareva dire: Scusatemi, è una cosa che non accade tutti i giorni.
La morte di un padre non sorprende spesso i giovani tra gli splendori della vita, tra le follie di un’orgia? La morte è improvvisa nei suoi capricci come una cortigiana nei suoi disdegni; ma, più fedele, non ha mai ingannato nessuno.
Quando richiuse la porta della sala e si avviò in una lunga galleria fredda e oscura, Don Giovanni si studiò di assumere un contegno teatrale; poiché, pensando al suo ruolo di figlio, aveva gettato via la gioia insieme al tovagliolo. La notte era nera. Il silenzioso domestico che conduceva il giovane verso una camera mortuaria faceva debolmente luce al suo padrone, così che la Morte, aiutata dal freddo, dal silenzio, dall’oscurità, poté far scivolare – forse soltanto per effetto del vino – pensieri gravi nell’anima di quel dissipatore; si interrogò sulla sua vita e divenne pensoso come chi si incammina verso il tribunale.
Bartolomeo Belvidero, padre di Don Giovanni, era un vecchio novantenne che aveva dedicato gran parte della sua vita agli affari. Avendo percorso spesso le fortunate contrade dell’Oriente, vi aveva acquistato numerose ricchezze e conoscenze più preziose, diceva, dell’oro e dei diamanti, dei quali allora non si dava più pensiero. «Preferisco un dente a un rubino, e il potere al sapere» diceva spesso sorridendo. Quell’ottimo padre godeva nell’ascoltare Don Giovanni narrargli una sventatezza giovanile, e diceva con aria beffarda, regalandogli denaro a piene mani: «Mio caro ragazzo, fa’ solo le sciocchezze che ti divertono». Era l’unico vecchio per il quale vedere un giovane fosse una gioia: l’amore paterno ingannava la sua caducità con la contemplazione di una vita tanto brillante. A sessant’anni Belvidero si era innamorato di un angelo di pace e di bellezza. Don Giovanni era stato l’unico frutto di quell’amore tardivo e passeggero. Da quindici anni il vecchio rimpiangeva la perdita della sua cara Giovanna.
La numerosa servitù e il figlio attribuivano al suo dolore di vecchio le singolari abitudini che aveva assunto. Rifugiatosi nell’ala più disagevole del palazzo, Bartolomeo ne usciva raramente, e lo stesso Don Giovanni non poteva entrarvi senza il permesso del padre. Se poi quell’anacoreta andava e veniva nel palazzo o nelle strade di Ferrara, sembrava cercare qualcosa che gli mancava; passeggiava con aria sognante, indecisa, ansioso come un uomo in guerra con un’idea o con un ricordo. Mentre il giovane Belvidero dava feste sontuose e il palazzo risuonava degli echi della sua gioia, mentre i cavalli scalpitavano nei cortili e i paggi litigavano giocando a dadi nei giardini, Bartolomeo mangiava sette once di pane al giorno e beveva acqua. Se chiedeva del pollo, era per darne le ossa allo spaniel nero, suo fedele compagno. Non si lamentava mai del rumore. Nel corso della sua malattia, se il suono del corno e l’abbaiare dei cani lo sorprendevano nel sonno, si limitava a dire: «Ah! È Don Giovanni che ritorna». Non si era mai visto sulla terra un padre tanto indulgente e tollerante; e il giovane Belvidero, abituato a trattarlo senza cerimonie, aveva tutti i difetti dei ragazzi viziati; viveva con Bartolomeo come una cortigiana capricciosa vive con un vecchio amante, facendosi perdonare un’impertinenza con un sorriso, vendendo il suo buon umore e lasciandosi amare. Ricostruendo nel pensiero i suoi anni giovanili, Don Giovanni comprese ora che gli sarebbe stato difficile cogliere in fallo la bontà di suo padre. Mentre percorreva la galleria, sentendo nascere in fondo al cuore un rimorso, giunse quasi a perdonare Bartolomeo per aver vissuto tanto a lungo. Tornava a sentimenti di pietà filiale, come un ladro si muta in uomo onesto per il possibile godimento di un milione ben nascosto. Presto il giovane percorse le alte e fredde sale che costituivano l’appartamento di suo padre. Dopo aver conosciuto un’atmosfera umida, respirato l’aria pesante, l’odore rancido che esalavano dalle vecchie tappezzerie e dagli armadi coperti di polvere, si trovò nella camera antica di suo padre, dinanzi a un letto nauseabondo, presso un focolare quasi spento. Una lampada, posata su un tavolo di forma gotica, gettava a intervalli irregolari sprazzi di luce più o meno forti sul letto, rivelando in modo ogni volta diverso il volto del vecchio. Il freddo sibilava attraverso i vetri mal chiusi, e la neve batteva sulle vetrate con un rumore sordo.
La scena era in violento contrasto con quella che Don Giovanni aveva appena lasciato, al punto che egli non poté impedirsi di trasalire. Poi si sentì raggelare, quando, avvicinandosi al letto, una violenta raffica di luce, spinta da un colpo di vento, illuminò la testa di suo padre: i lineamenti erano disfatti, la pelle, incollata alle ossa, aveva una tinta verdastra che il candore del guanciale sul quale il vecchio riposava faceva risaltare orribilmente; contratta dal dolore, la bocca semiaperta e priva di denti emetteva brevi sospiri alla cui lugubre energia facevano da contrappunto gli urli della tempesta. Pure, con tutti i segni della distruzione, splendeva su quel viso un senso di straordinaria potenza. Uno spirito superiore vi combatteva la morte. Gli occhi, infossati dalla malattia, conservavano una penetrazione singolare. Sembrava che Bartolomeo cercasse di uccidere, col suo sguardo di moribondo, un nemico seduto ai piedi del letto.
Quello sguardo fisso e freddo era tanto più spaventoso poiché la testa rimaneva immobile, simile ai teschi che si vedono posati su un tavolo negli studi medici. Il corpo, delineato dalle lenzuola, rivelava una identica immobilità nelle membra. Tutto era morto, tranne gli occhi. Infine, i suoni che uscivano dalla sua bocca avevano qualcosa di meccanico. Don Giovanni provò una certa vergogna nel giungere al letto del padre morente con i fiori di una cortigiana in seno, portandovi il profumo di una festa e l’odore del vino.
«Ti diverti!» esclamò il vecchio scorgendo il figlio.
Nello stesso istante la voce pura e leggera di una donna che incantava gli invitati, resa più forte dagli accordi della viola con la quale si accompagnava, dominò il fragore dell’uragano e risuonò fino alla camera funebre. Don Giovanni volle ignorare quella selvaggia conferma delle parole paterne.
Bartolomeo disse: «Non te ne voglio, ragazzo mio».
Quelle parole piene di dolcezza ferirono Don Giovanni, che non perdonò al padre la sua straziante bontà.
«Quali rimorsi per me, padre mio!» rispose ipocritamente.
«Povero Giovannino» riprese il moribondo con voce sorda «sono sempre stato tanto dolce con te che non sai dunque desiderare la mia morte?»
«Oh!» esclamò Don Giovanni «se fosse possibile ridarvi la vita, offrendo una parte della mia!» Queste cose si possono sempre dire, pensava quel libertino, è come se offrissi il mondo alla mia amante! Aveva appena finito di pensare, che lo spaniel abbaiò. Quella voce intelligente fece fremere Don Giovanni, che si sentì compreso dal cane.
«Sapevo bene, figlio mio, di poter contare su di te» esclamò il moribondo. «Io vivrò; vedrai, sarai contento. Vivrò, ma senza toglierti uno solo dei giorni che ti appartengono.»
Delira si disse Don Giovanni. Poi aggiunse a voce alta: «Sì, padre caro, voi vivrete quanto me, poiché la vostra immagine sarà sempre nel mio cuore».
«Non parlo di questo genere di vita» ribatté il vecchio radunando le forze per sedersi sul letto, colpito da uno di quei sospetti che nascono soltanto nei moribondi. «Ascolta, figlio mio» riprese con la voce indebolita da quell’ultimo sforzo «non desidero morire come tu non desideri rinunciare alle tue amanti, al vino, ai cavalli, ai falconi, ai cani e all’oro.»
Lo credo bene pensò ancora il figlio inginocchiandosi al capezzale del padre e baciando una delle mani cadaveriche di Bartolomeo. «Ma» riprese a voce alta «mio caro padre, bisogna sottomettersi alla volontà di Dio.»
«Dio sono io» replicò il vecchio, borbottando.
«Non bestemmiate» esclamò il giovane vedendo l’aria minacciosa che assumevano i lineamenti paterni. «Guardatevene bene; avete ricevuto l’estrema unzione, e non mi consolerei mai di vedervi morire da peccatore.»
«Vuoi ascoltarmi?» disse il morente con una smorfia rabbiosa.
Don Giovanni tacque. Regnò un orribile silenzio. Attraverso il sibilo pesante della neve giunsero nuovamente gli accordi della viola e quella voce incantevole, lievi come un giorno nascente. Il moribondo sorrise.
«Ti ringrazio di avere invitato delle cantatrici, dei musicanti. Una festa, donne giovani e belle, bianche, dai capelli neri! Tutti i piaceri della vita, falli restare; rinascerò.»
«Il delirio è al massimo» disse Don Giovanni.
«Ho scoperto un modo per rinascere. Cerca nel cassetto del tavolo, si apre schiacciando una molla nascosta dal grifone.»
«Ecco, padre mio.»
«Bene, prendi un piccolo flacone di cristallo di rocca.»
«Eccolo.»
«Ho impiegato vent’anni a…» In quel momento il vecchio sentì avvicinarsi la fine e raccolse tutte le sue forze per dire: «Appena avrò esalato l’ultimo respiro, mi strofinerai interamente con quell’acqua, e io rinascerò».
«Ve n’è ben poca» ribatté il giovane.
Se non poteva più parlare, Bartolomeo aveva ancora la facoltà di sentire e di vedere; a quelle parole la sua testa si volse verso Don Giovanni in un gesto orrendamente brusco, il collo rimase contorto come quello di una statua di marmo che la volontà dello scultore ha condannato a guardare di lato, gli occhi spalancati contrassero una spaventosa immobilità. Era morto, morto perdendo la sua sola, ultima illusione. Cercando rifugio nel cuore del figlio, vi aveva trovato una tomba più profonda di quella che gli uomini scavano per i loro morti. E l’orrore gli scompose i capelli, e il suo sguardo parlava ancora: era un padre che si sollevava con rabbia dal sepolcro per chiedere vendetta a Dio.
«Guarda! il poveretto è finito» esclamò Don Giovanni.
Mosso dall’ansioso desiderio di vedere il misterioso cristallo alla luce della lampada, come un bevitore guarda la bottiglia alla fine del pasto, Don Giovanni non aveva visto sbiancare l’occhio di suo padre. Il cane, la bocca spalancata, guardava il padrone morto e l’elisir, come Don Giovanni guardava, di volta in volta, suo padre e il flacone. La lampada gettava luci vacillanti. Il silenzio era profondo, la viola taceva. Belvidero trasalì credendo di vedere suo padre muoversi. Intimidito dall’espressione rigida di quegli occhi accusatori, li chiuse come avrebbe chiuso una persiana battuta dal vento in una notte d’autunno. Rimase fermo, immobile, perduto in un mondo di pensieri. A un tratto un rumore secco, simile a quello di una molla arrugginita, ruppe il silenzio. Don Giovanni, sorpreso, rischiò di lasciar cadere il flacone. Un sudore freddo, più freddo dell’acciaio di un pugnale, gli uscì da tutti i pori. Un gallo di legno dipinto scaturì dall’alto di un orologio e cantò tre volte; si trattava di una di quelle macchine ingegnose dalle quali i sapienti dell’epoca si facevano svegliare a una determinata ora. L’alba tingeva di rosa i vetri delle finestre. Don Giovanni aveva trascorso dieci ore riflettendo. Il vecchio orologio era più fedele al suo compito di quanto non lo fosse Belvidero nell’adempimento dei suoi doveri verso Bartolomeo. Quel meccanismo era fatto di legno, pulegge, corde, ingranaggi, mentre Don Giovanni aveva il meccanismo proprio dell’uomo, chiamato cuore. Per non esporsi più al rischio di perdere il misterioso liquore, lo scettico Don Giovanni lo ripose nel cassetto della piccola tavola gotica. In quel momento solenne udì venire dalle gallerie un rumore sordo: erano voci confuse, risa soffocate, passi leggeri, fruscii di seta, gli echi di un’allegra brigata che cerca di trovare il raccoglimento. La porta si aprì: il principe, gli amici di Don Giovanni, le sette cortigiane, le cantatrici, apparvero nel bizzarro disordine in cui si trovano le danzatrici sorprese dalla luce del mattino, quando il sole lotta con la pallida luce delle candele. Venivano tutti per porgere al giovane erede il conforto consueto.
«Oh! Oh! il povero Don Giovanni ha dunque preso sul serio questa morte?» mormorò il principe all’orecchio della Brambilla.
«Suo padre era molto buono» rispose lei.
Tuttavia le meditazioni notturne avevano dato al volto di Don Giovanni un’espressione così stupefacente, che impose silenzio al gruppo. Gli uomini rimasero immobili. Le donne, le cui labbra erano aride per il vino, le guance segnate dai baci, si inginocchiarono e incominciarono a pregare. Don Giovanni trasalì vedendo gli splendori, le gioie, le risa, i canti, la giovinezza, la bellezza, il potere, la vita stessa personificata, prosternarsi dinnanzi alla morte. Ma in quella adorabile Italia la dissolutezza e la religione si univano allora al punto che la religione era dissolutezza e la dissolutezza una religione! Il principe strinse affettuosamente la mano di Don Giovanni; poi, i volti avendo assunto tutti simultaneamente un’espressione triste e indifferente a un tempo, la fantasmagorica brigata scomparve, e la sala rimase vuota. Autentica immagine della vita! Scendendo lo scalone il principe disse alla Rivabarella: «Chi avrebbe creduto che Don Giovanni fosse falso nella sua empietà? Ama suo padre!».
«Avete osservato il cane nero?» chiese la Brambilla.
«Ecco Don Giovanni immensamente ricco» ribatté sospirando Bianca Cavatolino.
«Che importa!» esclamò la fiera Varonese, quella che aveva rotto la confettiera.
«Come, che importa?» esclamò il duca. «Con tutti i suoi scudi è principe quanto me.»
Dapprima Don Giovanni, in equilibrio tra mille pensieri, non seppe risolvere quale decisione prendere. Dopo aver tratto ispirazione dal tesoro accumulato da suo padre, tornò verso sera nella camera mortuaria, l’anima appesantita da uno spaventoso egoismo. Trovò nell’appartamento la servitù impegnata a raccogliere gli ornamenti con cui avrebbero parato il letto dove il defunto sarebbe stato esposto l’indomani, al centro di una superba camera ardente, curioso spettacolo che tutta Ferrara doveva venire a ammirare. Don Giovanni fece un cenno, e la servitù si fermò, tremante, perplessa.
«Lasciatemi solo» disse con voce mutata. «Tornerete solo nel momento in cui io uscirò!»
Quando i passi del vecchio servitore che uscì per ultimo risuonarono sempre più lontani, Don Giovanni chiuse precipitosamente la porta e, sicuro di essere solo, esclamò: «Proviamo!».
Il corpo di Bartolomeo giaceva su una lunga tavola. Per sottrarre agli sguardi l’orrendo spettacolo di un cadavere che l’estrema vecchiaia e la magrezza rendevano simile a uno scheletro, gli imbalsamatori avevano avvolto il corpo in un sudario che lasciava libera solo la testa. Quella sorta di mummia giaceva al centro della stanza, e il sudario, di stoffa morbida, ne disegnava vagamente le forme, ma aguzze, rigide, gracili. Il viso era già segnato da larghe macchie violacee, che rivelavano la necessità di compiere l’imbalsamazione. Sebbene protetto da una corazza di scetticismo, Don Giovanni tremava, stappando la magica fiala di cristallo, e quando giunse vicino alla testa fu costretto a fermarsi pochi istanti, tanto era il tremito che lo scuoteva. Ma il giovane era stato molto presto sapientemente corrotto dai costumi di una corte dissoluta: una riflessione degna del duca di Urbino gli diede dunque il coraggio, reso affilato da un vivo senso di curiosità, e sembrò che il demonio stesso gli suggerisse le parole che gli risuonarono in cuore: Bagnagli un occhio!. Prese un panno di lino e, dopo averlo imbevuto con parsimonia del prezioso liquore, lo passò leggermente sulla palpebra destra del cadavere. L’occhio si aprì.
«Ah! Ah!» esclamò Don Giovanni stringendo il flacone in mano, come noi stringiamo, in sogno, il ramo al quale siamo sospesi al di sopra di un precipizio.
Vedeva un occhio pieno di vita, un occhio di bambino in un teschio, dove la luce tremava in un fluido giovane; protetta dalle belle ciglia nere, scintillava come quelle luci che il viaggiatore scorge per la campagna deserta, nelle sere d’inverno. Quell’occhio fiammeggiante sembrava volesse lanciarsi su Don Giovanni, e pensava, accusava, condannava, minacciava, giudicava, parlava, gridava, mordeva. Vi si agitavano tutte le passioni umane; le suppliche più tenere, una collera regale, l’amore di una giovane donna che chiede grazia ai suoi carnefici; lo sguardo profondo che un uomo getta agli altri uomini mentre sale l’ultimo gradino del patibolo. Splendeva tanta vita in quel frammento di vita, che Don Giovanni, spaventato, si ritrasse, passeggiò per la stanza senza osare di guardare l’occhio che rivedeva sui pavimenti, sulle tappezzerie. La stanza era disseminata di punte piene di fuoco, di vita, d’intelligenza. Dappertutto brillavano occhi che gli abbaiavano contro! «Avrebbe certo rivissuto cento anni» esclamò involontariamente, nell’istante in cui, richiamato davanti al padre da una volontà diabolica, contemplava quella scintilla luminosa.
A un tratto la palpebra viva si chiuse e si riaprì in un moto brusco, come quella di una donna che acconsente. Se una voce avesse gridato: Sì! Don Giovanni non avrebbe provato terrore più grande.
Che fare? pensò. Trovò il coraggio di provare a chiudere la palpebra bianca. I suoi sforzi furono inutili.
Cavarlo? Sarà forse un parricidio? si chiese.
Sì disse l’occhio con un battere di ciglia di stupefacente ironia.
«Ah» esclamò Don Giovanni «questo è effetto di stregoneria!» Si avvicinò all’occhio per cavarlo. Una grossa lacrima rotolò sulla guancia incavata del cadavere, e cadde sulla mano di Belvidero.
«Brucia» esclamò lui sedendosi.
Quella lotta lo aveva affaticato come se avesse combattuto, sull’esempio di Giacobbe, contro un angelo.
Infine si alzò dicendo a se stesso: Purché non vi sia sangue. Poi, facendo appello a tutto il coraggio necessario per essere vile, cavò l’occhio premendolo con un lino, ma senza guardarlo. Si sentì un gemito inatteso e terribile. Il povero spaniel spirava urlando.
Che sia anche lui partecipe del segreto? si chiese Don Giovanni guardando il fedele animale.
Don Giovanni Belvidero apparve agli occhi del mondo un figlio pietoso. Innalzò un monumento di marmo bianco sulla tomba del padre e ordinò l’esecuzione delle statue ai più celebri artisti del tempo. Si sentì perfettamente tranquillo soltanto quando la statua del padre, inginocchiato ai piedi della Religione, chiuse con tutto il suo peso la fossa, dove egli seppellì il solo rimorso che mai abbia sfiorato il suo cuore nei momenti di stanchezza fisica. Inventariando le immense ricchezze accumulate dal vecchio orientalista, Don Giovanni diventò avaro: non aveva due vite umane alle quali provvedere? Il suo sguardo profondamente scrutatore penetrò l’essenza della vita sociale, e comprese meglio il mondo, poiché lo vedeva attraverso una tomba. Analizzò gli uomini e le cose e in un colpo solo si liberò del passato, rappresentato dalla Storia; del presente, configurato dalla Legge; dell’avvenire, svelato dalla Religione. Prese l’anima e la materia, le gettò in un crogiolo, non vi trovò nulla, e da allora divenne DON GIOVANNI! Maestro delle illusioni della vita, si slanciò, giovane e bello, nella vita, disprezzando il mondo, ma del mondo impadronendosi. La sua felicità non poteva essere la felicità borghese che gode di un bollito a scadenze fisse, di uno scaldaletto l’inverno, di una lampada per la notte e di un paio di pantofole nuove ogni tre mesi. No, Don Giovanni afferrò l’esistenza come una scimmia afferra una noce, e senza gingillarsi la privò sapientemente del volgare involucro per affrontarne la polpa saporita. La poesia e i sublimi entusiasmi della passione non gli andarono più alla caviglia. Non commise l’errore di molti uomini potenti, quando, convinti a volte che le piccole anime credono alle grandi, decidono di scambiare gli alti pensieri dell’avvenire contro la moneta spicciola delle nostre idee quotidiane. Poteva benissimo, come loro, camminare con i piedi per terra e la testa nelle nuvole; ma preferiva sedersi, e inaridire con i suoi baci più di una bocca femminile, tenera, fresca, profumata; poiché, simile alla morte, là dove passava divorava tutto senza pudore, volendo un amore di semplice possesso, un amore orientale, dai piaceri lunghi e facili. Amando solo la donna nelle donne, fece dell’ironia un aspetto naturale della sua anima. Se le sue amanti si servivano di un letto per perdersi nei fumi di un’estasi inebriante, Don Giovanni le seguiva, grave, espansivo, sincero quanto sa esserlo uno studente tedesco. Ma egli diceva io quando la sua amante, folle, perduta, diceva NOI. Era maestro nell’arte di lasciarsi trasportare da una donna. Sapeva sempre essere tanto forte da farle credere di tremare come un liceale quando dice alla sua prima dama, in un ballo: «Amate la danza?». Tuttavia sapeva ruggire a proposito, sfoderare la spada, e uccidere un Commendatore.
La sua semplicità aveva una nota canzonatoria, e una sfumatura di riso vibrava nelle sue lacrime, poiché egli ha sempre saputo piangere come una donna quando dice al marito: «Regalami una carrozza o morirò di tisi». Per i negozianti il mondo è un pacco o un fascio di banconote; per molti giovani è una donna; per qualche donna è un uomo; per alcune menti è un salotto, una consorteria, un quartiere, una città; per Don Giovanni l’universo era lui! Modello di grazia e di nobiltà, spirito seducente, ancorò la sua barca a tutte le rive; ma, pur facendosi condurre, andava dove voleva essere condotto. Più visse, più dubitò. Esaminando gli uomini, indovinò spesso che il coraggio era temerarietà; la prudenza viltà; la generosità astuzia; la giustizia un crimine; la delicatezza balordaggine; la probità organizzazione: e per una fatalità singolare comprese che chi è autenticamente probo, delicato, giusto, generoso, prudente e coraggioso non è tenuto in alcun conto dagli uomini. Che gelido scherzo si disse. Non viene certo da un Dio. E, rinunciando a un mondo migliore, non si tolse mai il cappello pronunciando un Nome, e considerò i santi di pietra nelle chiese come opere d’arte. Comprendendo poi il meccanismo delle società umane, non urtava mai troppo i pregiudizi poiché non era potente come il carnefice; ma aggirava le leggi sociali con la grazia e lo spirito rappresentati da Monsieur Dimanche. Egli fu, in realtà, il prototipo del Don Giovanni di Molière, del Faust di Goethe, del Manfredi di Byron, e del Melmoth di Maturin. Grandi immagini tracciate dai maggiori geni d’Europa, alle quali non mancheranno forse né gli accordi di Mozart né la lira di Rossini! Immagini terribili che il principio del male, presente in ogni uomo, eternizza, e che si ripresentano da un secolo all’altro: entrando in trattative con gli uomini come Mirabeau; scegliendo i fatti e non le parole come Bonaparte; racchiudendo l’universo nell’ironia come il divino Rabelais; o ridendo degli esseri umani, e non insultando le cose, come il maresciallo di Richelieu; o, meglio ancora, prendendosi gioco allo stesso tempo degli uomini e delle cose, come il più celebre dei nostri ambasciatori. Ma il genio profondo di Don Giovanni Belvidero riassunse e anticipò tutti quei geni. Don Giovanni si fece beffe di tutto. La sua vita era una canzonatura che comprendeva uomini, cose, istituzioni, idee. Quanto all’eternità, aveva parlato familiarmente per una mezz’ora con papa Giulio II, e alla fine della conversazione gli disse ridendo: «Se devo assolutamente scegliere preferisco credere in Dio piuttosto che nel diavolo; la potenza unita alla bontà offre maggiori risorse di quante ne abbia il genio del male».
«Sì, ma Dio vuole che in questo mondo si faccia penitenza…»
«Pensate dunque sempre alle indulgenze? Ebbene! per pentirmi delle colpe della mia vita ho tutta una esistenza di riserva.»
«Ah, se vedi così la vecchiaia!» esclamò il papa «rischi di essere canonizzato.»
«Dopo la vostra elezione al soglio pontificio si può credere a tutto.»
E andarono a vedere gli uomini che costruivano l’immensa basilica dedicata a San Pietro.
«San Pietro è l’uomo di genio che ci ha investiti di un doppio potere» disse il papa a Don Giovanni. «Merita questo monumento. Ma qualche volta, di notte, penso che un diluvio vi passerà sopra la spugna, e che bisognerà ricominciare…»
Don Giovanni e il papa risero insieme; si erano compresi. Uno sciocco sarebbe andato l’indomani a divertirsi con Giulio II da Raffaello, o nella deliziosa Villa Madama; ma Belvidero andò a vederlo officiare la Messa pontificale per rafforzarsi nei suoi dubbi. Nel corso di un’orgia Della Rovere avrebbe potuto smentirsi e commentare l’Apocalisse.
Tuttavia questa leggenda non ha per scopo di fornire materiale a quanti vorranno scrivere la vita di Don Giovanni; è destinata a provare alle persone oneste che Don Giovanni non è morto in duello con una statua di pietra, come vogliono far credere alcuni litografi. Quando Don Giovanni Belvidero toccò i sessant’anni, si stabilì in Spagna. Là, alle soglie della vecchiaia, sposò una giovane e bella andalusa. Ma, per calcolo, non fu né un padre né un buon marito. Aveva osservato che non si è mai amati tanto teneramente come si è amati dalle donne alle quali non si pensa mai. Donna Elvira, educata santamente da una zia che viveva in un castello in fondo all’Andalusia, a qualche lega da San Lucar, era tutta grazia e devozione. Don Giovanni intuì che la giovane donna era in grado di combattere a lungo una passione prima di cedervi, e sperò di poterla conservare virtuosa fino alla morte. Fu uno scherzo serio, una partita a scacchi che volle riservarsi di giocare in tarda età. Forte di tutti gli errori commessi da suo padre Bartolomeo, volle che ogni azione della sua vecchiaia servisse alla riuscita del dramma che doveva aver luogo al suo letto di morte. Gran parte delle sue ricchezze rimase dunque nascosta nei sotterranei del palazzo di Ferrara, dove andava raramente. Quel che restava della sua fortuna fu investito in una rendita vitalizia affinché la moglie e i figli fossero interessati alla lunghezza della sua vita: astuzia della quale avrebbe dovuto servirsi suo padre; ma tanta machiavellica perfezione gli fu ben poco necessaria. Il giovane Filippo Belvidero, suo figlio, divenne uno spagnolo tanto coscienziosamente religioso quanto suo padre era empio, forse in virtù del proverbio: A padre avaro, figlio prodigo. Per guidare la coscienza della duchessa di Belvidero e di Filippo, Don Giovanni scelse l’abate di San Lucar. L’ecclesiastico era un sant’uomo, di bell’aspetto, mirabilmente proporzionato, con begli occhi neri, una testa alla Tiberio affaticata dai digiuni, pallida per i sacrifici; e era tentato ogni giorno come lo sono tutti i solitari. Il vecchio gentiluomo sperava forse di poter rovinare un monaco prima di concludere il suo primo periodo di vita. Ma forse perché l’abate era forte quanto poteva esserlo lui, forse perché Donna Elvira aveva più prudenza e virtù di quante la Spagna non ne conceda alle donne, Don Giovanni fu costretto a passare i suoi ultimi giorni come un curato di campagna, senza ombra di scandali in casa sua. A volte provava gusto a cogliere in fallo Filippo e la duchessa nei loro doveri religiosi, e esigeva imperiosamente che seguissero tutti gli obblighi imposti ai fedeli da Roma. In breve, non era mai tanto felice come quando sentiva il galante abate di San Lucar, Donna Elvira e Filippo intenti a discutere un caso di coscienza.
Frattanto, pur con le straordinarie cure che Don Giovanni Belvidero aveva per la sua persona, vennero i giorni della decrepitezza e con quell’età di sofferenze vennero le crisi di impotenza, crisi tanto più laceranti quanto più ricchi erano i ricordi della sua ardente giovinezza e della voluttuosa maturità. L’uomo che aveva toccato l’estremo grado dello scherno costringendo gli altri a credere a leggi e principi dei quali egli si faceva beffe, si addormentava la sera con un Forse! Il modello di buone maniere, il duca vigoroso in un’orgia, superbo nelle corti, garbato con le donne il cui cuore aveva piegato come un contadino piega un ramo di giunco, l’uomo di genio soffriva di vomito, di una fastidiosa sciatica, di una gotta brutale. Vedeva i denti abbandonarlo come, alla fine di una festa, le dame più bianche, le meglio vestite, se ne vanno a una a una, lasciando il salone deserto e privo di ornamenti. Le sue mani audaci tremarono, le gambe vacillarono, e una sera l’apoplessia lo strinse alla gola con le dita uncinate e glaciali. Da quel giorno fatale Don Giovanni divenne tetro e duro. Calunniava la devozione del figlio e della moglie affermando che le loro cure commoventi e delicate gli venivano prodigate soltanto perché aveva investito tutta la sua fortuna in rendite vitalizie. Elvira e Filippo piangevano amare lacrime e raddoppiavano le carezze a quel vecchio malizioso la cui voce spezzata si faceva affettuosa per dire: «Miei cari, mia diletta moglie, mi perdonate, non è vero? So di tormentarvi. Ahimè, Signore, come ti servi di me per tormentare queste due celesti creature? Io, che dovrei essere la loro gioia, sono il loro flagello».
In tal modo li incatenò al suo capezzale, facendo dimenticare lunghi mesi di impazienza e di crudeltà per un’ora nella quale dispensava sempre nuovi tesori della sua grazia e di una falsa tenerezza. Sistema paterno che a lui riuscì infinitamente meglio di quanto, una volta, fosse riuscito quello di suo padre verso di lui. Infine la malattia assunse un tale stato di gravità che, per metterlo a letto, bisognava manovrarlo come un vascello che debba entrare in un canale pericoloso. Poi venne il giorno della morte. Quell’uomo brillante e scettico in cui solo la lucidità mentale sopravviveva alla più paurosa distruzione si vide tra un medico e un confessore, le sue due inveterate antipatie. Ma fu cordiale con loro. Forse che per lui il velo dell’avvenire non celava una luce scintillante? Su quel sipario, di piombo per gli altri e diafano per lui, le leggere, meravigliose delizie della giovinezza giocavano come ombre.
In una bella sera d’estate Don Giovanni sentì avvicinarsi la morte. Il cielo di Spagna era di una purezza mirabile, gli aranci profumavano l’aria, la luce delle stelle era viva e fresca, la natura sembrava dargli promesse certe di una sua resurrezione, un figlio devoto e obbediente lo contemplava con amore e rispetto. Verso le undici volle rimanere solo con quel candido essere.
«Filippo» gli disse con voce così tenera e affettuosa che il giovane trasalì e pianse di commozione. Mai quel padre inflessibile aveva pronunciato così: Filippo!. «Ascoltami, figlio mio» riprese il moribondo. «Sono un grande peccatore, e per tutta la vita ho pensato alla morte. Un tempo sono stato amico del grande papa Giulio II. L’illustre pontefice, temendo che l’eccessiva vivacità dei sensi mi facesse commettere qualche peccato mortale tra il momento della mia morte e quello in cui avevo ricevuto l’Olio Santo, mi regalò una fiala che contiene l’acqua santa scaturita un tempo dalle rocce nel deserto. Ho tenuto segreta questa dilapidazione del tesoro della Chiesa, ma sono autorizzato a rivelare il mistero a mio figlio in articulo mortis. Troverai la fiala nel cassetto di quella tavola gotica che non ha mai abbandonato il mio capezzale… Il prezioso cristallo potrà servirti ancora, mio amato Filippo. Giurami sulla vita eterna di eseguire puntualmente i miei ordini.»
Filippo guardò il padre. Don Giovanni conosceva troppo bene le espressioni umane per non morire in pace, confortato da quello sguardo, come il padre era morto disperato vedendo il suo.
«Meriteresti un altro padre» riprese. «Oso confessarti, ragazzo mio, che nel momento in cui il rispettabile abate di San Lucar mi amministrava il Viatico io pensavo all’incompatibilità di due grandi potenze come quelle del diavolo e di Dio…»
«Oh, padre mio!»
«E mi dicevo che quando Satana si metterà in pace dovrà, se non vuole essere un gran miserabile, ottenere il perdono anche per i suoi adepti. Questo pensiero non mi ha abbandonato; andrei dunque all’inferno, figlio mio, se tu non compissi le mie volontà.»
«Oh, ditemele subito!»
«Appena avrò chiuso gli occhi per sempre, forse tra qualche minuto, prenderai il mio corpo ancora caldo e lo adagerai su una tavola al centro di questa camera. Poi spegnerai la lampada; deve bastarti la luce delle stelle. Mi spoglierai delle vesti, e mentre reciterai dei Pater e delle Ave Maria, elevando a Dio la tua anima, avrai cura di bagnarmi con quell’acqua santa gli occhi, le labbra, tutta la testa; quindi le membra e il corpo; ma, figlio mio, la potenza di Dio è così grande che non dovrai stupirti di nulla!»
A questo punto Don Giovanni sentì venire la morte, e aggiunse con voce terribile: «Tieni bene il flacone». Poi spirò dolcemente tra le braccia del figlio le cui lacrime gli caddero sul viso ironico e livido.
Era circa mezzanotte quando Don Filippo Belvidero mise il cadavere del padre sulla tavola. Dopo aver baciato la fronte minacciosa e i capelli grigi, spense la lampada. La dolcezza del chiaro di luna, i cui riflessi bizzarri illuminavano la campagna, permise al pietoso Filippo di intravedere il corpo del padre come una forma bianca nell’ombra. Il giovane imbevve un lino nel liquido, e, immerso nella preghiera, nel più profondo silenzio, bagnò fedelmente quella testa per lui sacra. Sentì fremiti indescrivibili, ma li attribuì ai giochi della brezza tra le cime degli alberi. Quando ebbe bagnato il braccio destro si sentì stringere con forza il collo da un braccio giovane e vigoroso; il braccio di suo padre! Gettò un grido lacerante, e lasciò cadere la fiala che si ruppe. Il liquore evaporò. Accorse la servitù del castello munita di fiaccole. Il grido li aveva spaventati e sorpresi, come se la tromba del giudizio finale avesse fatto tremare l’universo. In un attimo la stanza si riempì di gente. La folla tremante intravide Filippo svenuto, ma sorretto dal braccio forte del padre, che lo stringeva al collo. Poi, prodigiosamente, i presenti videro la testa di Don Giovanni giovane e bella come la testa di Antinoo; una testa dai capelli neri, dagli occhi brillanti, dalla bocca vermiglia, che si agitava paurosamente senza poter muovere lo scheletro al quale apparteneva. Un vecchio servitore gridò: «Miracolo!». E tutti gli spagnoli ripeterono: «Miracolo!».
Troppo religiosa per ammettere i misteri della magia, Donna Elvira mandò a cercare l’abate di San Lucar. Quando il priore vide il miracolo con i suoi occhi, decise di profittarne, da uomo di spirito e da abate lieto di aumentare le rendite. Dichiarando che Don Giovanni sarebbe stato senza dubbio canonizzato, indicò come luogo dell’apoteosi il suo convento, che si sarebbe chiamato ormai San Giovanni di Lucar. A queste parole la testa fece una smorfia ironica.
L’amore degli spagnoli per tali solennità è così noto che non deve essere difficile credere alle straordinarie feste religiose con le quali l’abbazia di San Lucar celebrò la traslazione del beato Don Giovanni Belvidero nella sua chiesa. Alcuni giorni dopo la morte di quell’illustre gentiluomo, il miracolo della sua imperfetta resurrezione si era tanto fittamente diffuso, di villaggio in villaggio, per più di cinquanta leghe intorno a San Lucar, che fu già uno spettacolo vedere i curiosi in cammino; vennero da ogni parte, attratti da un Te Deum cantato alla luce delle fiaccole.
L’ex moschea del convento di San Lucar, edificio meraviglioso costruito dai mori, sotto le cui volte risuonava da tre secoli il nome di Gesù Cristo in luogo di quello di Allah, non poté contenere la folla accorsa per assistere alla cerimonia. Stretti come formiche, hidalgo in mantelli di velluto e armati delle loro spade rimanevano in piedi attorno ai pilastri senza trovare il posto per piegare le ginocchia, che si piegavano solo in una chiesa. Splendide contadine di cui le vesti disegnavano le forme amorose davano il braccio a vecchi dai capelli bianchi. Giovani dagli occhi di fuoco erano a fianco di vecchie vestite a festa. E ancora coppie frementi di gioia; fidanzate curiose accompagnate dai loro amati, spose della vigilia, bambini spauriti che si tenevano per mano. Un mondo ricco di colori, brillante di contrasti, carico di fiori, smagliante, che faceva un dolce tumulto nel silenzio della notte.
I portali della chiesa vennero aperti. Quanti, giunti troppo tardi, rimasero fuori, vedevano da lontano, attraverso i tre portali spalancati, una scena di cui le vaporose decorazioni delle opere moderne non potrebbero dare neppure una pallida idea. Devote e peccatori, desiderosi di guadagnarsi la benevolenza di un nuovo santo, accesero migliaia di candele nella vasta chiesa, luci interessate che diedero toni magici all’edificio. Le nere arcate, le colonne e i capitelli, le profonde cappelle brillanti d’oro e d’argento, le gallerie, i trafori saraceni, le linee più delicate di quella delicata architettura si delineavano nella luce abbagliante come le figure capricciose che si formano in un braciere acceso. Era un oceano di fuoco, dominato, in fondo alla chiesa, dal coro dorato dove si innalzava l’altare maggiore, la cui gloria avrebbe rivaleggiato con quella del sole.
In realtà, lo splendore delle lampade d’oro, dei candelabri d’argento, degli stendardi, degli arredi, dei santi e degli ex-voto, impallidiva di fronte alla teca in cui giaceva Don Giovanni. Il corpo dell’empio scintillava di gemme, di fiori, di cristalli, di diamanti, d’oro, di piume bianche come le ali di un serafino, e sostituiva sull’altare un quadro del Cristo. Intorno a lui brillavano innumerevoli ceri che lanciavano in aria onde fiammeggianti. Il buon abate di San Lucar, parato degli abiti pontificali, la mitria arricchita da pietre preziose, il rocchetto, la croce d’oro, sedeva, re del coro, su una poltrona di un lusso imperiale, attorniato dal suo clero composto da impassibili vecchi dai capelli argentei che lo circondavano simili ai santi confessori che i pittori raggruppano attorno all’Eterno. Il maestro cantore e i dignitari del capitolo, decorati delle brillanti insegne della loro vanità ecclesiastica, andavano e venivano tra nuvole d’incenso, come astri che girino nel firmamento. Venuta l’ora del trionfo, le campane risvegliarono gli echi delle campagne, e tutta l’immensa assemblea lanciò verso Dio il primo grido di gloria che inizia il Te Deum. Grido sublime! Erano voci pure e leggere, voci di donne in estasi unite alle voci gravi e forti degli uomini; migliaia di voci così potenti che l’organo non riusciva a dominarle pur con il muggito delle sue canne. Solo le note penetranti delle giovani voci dei chierichetti unite ai larghi accenti di qualche basso suscitarono idee di grazia, raffigurarono l’infanzia e la forza in quel meraviglioso concerto di voci umane confuse in un sentimento d’amore.
«Te Deum laudamus!»
Dalla cattedrale gremita di donne e di uomini inginocchiati, il canto scaturì come una luce che scintilla di colpo nella notte, e il silenzio fu rotto come da un colpo di tuono. Le voci salirono con le nuvole di incenso che gettavano veli diafani e bluastri sulle fantastiche meraviglie dell’architettura. Tutto era ricchezza, profumo, luce e melodia. Nel momento in cui quella musica di riconoscenza e di amore salì verso l’altare, Don Giovanni, troppo educato per non ringraziare, troppo spiritoso per non accettare lo scherno, rispose con una risata spaventosa, e si distese nella teca. Ma il diavolo lo fece pensare alla possibilità di essere preso per un uomo come un altro, per un santo, un Bonifacio, un Pantaleone, e Don Giovanni turbò quella melodia d’amore con un urlo al quale si aggiunsero le mille voci dell’inferno.
La terra benediceva, il cielo malediceva. La chiesa ne tremò fino alle più antiche fondamenta.
«Te Deum laudamus!» pregava l’assemblea.
«Andate a tutti i diavoli, bruti che siete! Dio, Dio! Carajos demonios, animali, siete degli stupidi con il vostro Dio in figura di vecchio.»
E un torrente di imprecazioni si scatenò come un ruscello di lava ardente per un’eruzione del Vesuvio.
«Deus Sabaoth, Deus Sabaoth!» gridarono i cristiani.
«Insultate la maestà dell’inferno» rispose Don Giovanni digrignando i denti.
Quindi il braccio vivo poté passare sopra la teca, e minacciò l’assemblea con gesti pieni di disperazione e di ironia.
«Il santo ci benedice» dissero le vecchie, i bambini e le fidanzate, le creature più ingenue.
Ecco come siamo spesso ingannati nelle nostre adorazioni. L’uomo superiore ride di coloro che lo complimentano e complimenta qualcuno del quale si prende gioco in fondo al cuore.
Nel momento in cui l’abate, prosternato davanti all’altare, cantava: «Sancte Johannes, ora pro nobis!», sentì molto chiaramente: «O coglione!» In italiano nel testo (N.d.T.).. «Che succede lassù?» esclamò il vicepriore vedendo che la teca si muoveva.
«Il santo fa il diavolo» rispose l’abate.
Allora, la testa viva si staccò con violenza dal corpo che non viveva e cadde sul cranio giallo dell’officiante.
«Ricordati di Donna Elvira!» gridò la testa divorando quella dell’abate.
Quest’ultimo gettò un grido spaventoso che turbò la cerimonia. Tutti i preti accorsero e circondarono il loro sovrano.
«Imbecille, di’ dunque che c’è un Dio!» gridò la voce nel momento in cui l’abate, morso al cervello, esalava l’ultimo respiro.
Parigi, ottobre 1830
Il fantastico visionario
Crediti
Italo Calvino
Racconti fantastici dell'Ottocento
Il fantastico visionario
Pinterest • Joan Miró •
Racconti fantastici dell'Ottocento
Volume primoIl fantastico visionario
Pinterest • Joan Miró •










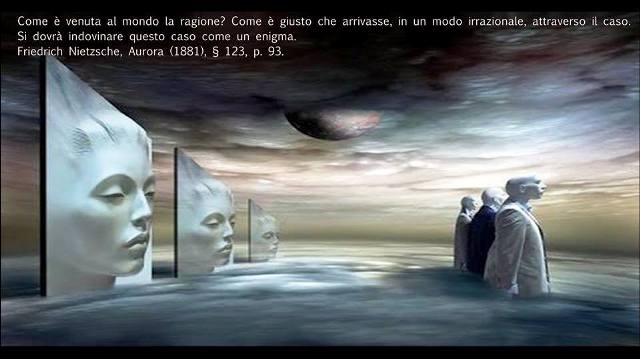
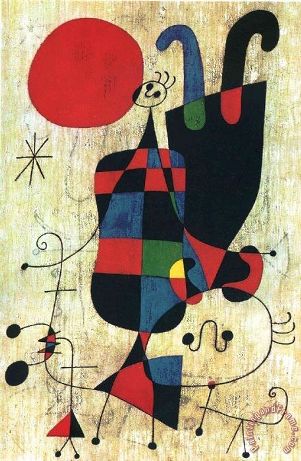
Ancora nessun commento